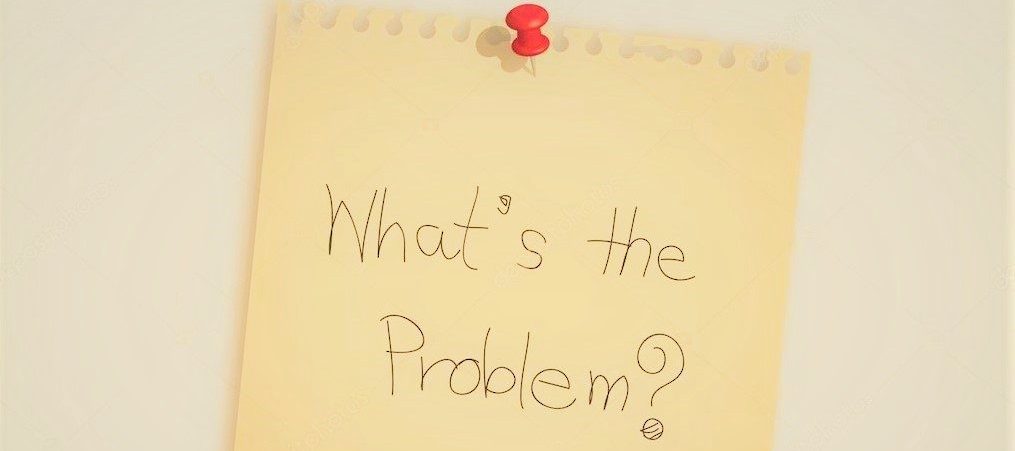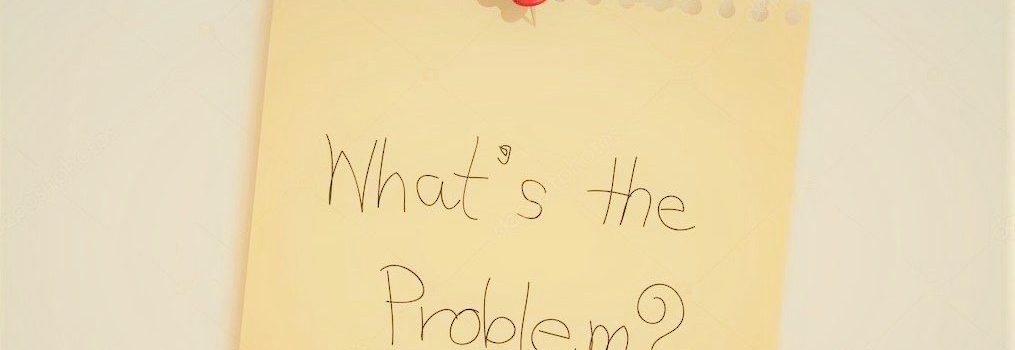“Questo non è un problema“. Tra l’essere normativi e il problematizzare nuovi criteri di osservazione dei minori
di Marta Pinto e Stefano Raimondo
“E’ sempre il come e il perché conosciamo a stabilire il cosa, non viceversa” (Salvini e Bottini, 2011)
Recentemente siamo stati incaricati di condurre un percorso di promozione di competenze linguistiche, con bambini e bambine di 2-3 anni, in risposta ad un finanziamento previsto per progetti sul linguaggio negli Asili e nelle Scuole dell’Infanzia. Nel corso di questa collaborazione abbiamo partecipato a una plenaria con insegnanti e genitori durante la quale è emersa una questione sentita e dibattuta: i problemi del linguaggio nei bambini sono dilagati e aumentati negli ultimi 15/20 anni?
Di fronte a questa domanda, è difficile non pensare agli insegnamenti di Goffman (2003), per esempio quando diceva che “..è la società a stabilire quali strumenti debbano essere usati per dividere le persone in categorie e quale complesso di attributi debbano essere considerati ordinari e naturali…è tipico non rendersi conto del fatto che siamo stati proprio noi a stabilire quei requisiti, quelle richieste…”.
Sfruttiamo un parallelismo. Qualche millennio fa erano i fulmini a dimostrare l’esistenza di Zeus o il contesto culturale di credenze e il relativo universo simbolico ad assegnare ai fulmini un certo senso e significato? Difficile avere dubbi al giorno d’oggi, ma nessuno parlerebbe di “disturbo meteorologico” (o qualcosa del genere) del popolo Greco. Certamente sulla base di tale concezione gli antichi Greci organizzavano pensieri e comportamenti, generando le ricadute concrete di una realtà costruita, della narrazione sociale: un mondo possibile. Come hanno sostenuto Peter L. Berger e Thomas Luckmann (1969) tale processo è trasversale alle epoche umane: da sempre l’essere umano organizza l’universo simbolico all’interno del quale declina il proprio vivere quotidiano. Questo è ciò che chiamiamo cultura.
Si tratta di rendersi conto che ogni narrazione è una costruzione, e non una constatazione dello “stato di natura” delle cose, ma che abbiamo necessità di una narrazione per poterci muovere nel mondo, e quindi si tratta di assumerci la responsabilità che abbiamo come osservatori, non tanto di negarci ogni tipo di definizione o retorica.
Una prima considerazione quindi è in merito al modo in cui definiamo cosa è “problema”.
Nella prospettiva interazionista non si parla di “scoperta” dei problemi, come se essi esistessero nell’Origine misteriosa della Realtà a priori. Né si parla di debellamento, come se fossero da estirpare, intrusi sgraditi in un mondo altrimenti perfetto.
La valutazione e il giudizio di ciò che è da ritenersi un problema è anche una costruzione dell’osservatore, dice Salvini (2007) “nel senso che è guidato: a) dalle credenze, teorie, pratiche e tecniche che usa; b) dalle attese culturali, istituzionali e giuridiche, cui deve dare una risposta entro vincoli preordinati e spesso fondati su presupposti culturali decaduti […] c) dagli schemi cognitivi e dai procedimenti linguistici da cui dipende la sua visione della realtà e la sua condizione di esperto; d) dal fatto che l’osservato non rimane indifferente alla relazione che lo definisce”.
Pertanto quando definiamo qualcosa come problematico questa definizione deve esserci utile a generare un cambiamento, indicarci una direzione, e non limitarsi a qualificare negativamente un qualcosa.
Una seconda considerazione va a riguardo delle differenze tra la scuola di oggi e quella di 20 anni fa, e sulla responsabilità che un processo educativo, o di formazione, implica rispetto alla comunità e alle richieste che questa pone.
Michel Foucault nel 1972 ha sostenuto “Ogni sistema di educazione è un modo politico di mantenere o di modificare l’appropriazione dei discorsi, con i saperi ed i poteri che essi comportano”, siamo quindi chiamati a interrogarci sulle implicazioni di questa appropriazione e sul potere di definire qualcosa come problematico all’interno di un sistema educativo.
Un’educatrice di scuola dell’infanzia ci racconta: “abbiamo dato a casa un silent book[1] e alcuni genitori sono venuti chiedendoci cosa se ne dovevano fare! questo è il livello…povertà di stimoli…”
L’intervento così posto assomiglia alla retorica del “ai miei tempi… (era meglio di adesso)”.
In questo passaggio è evidente come il modo di porre il problema non sia a servizio del cambiamento, ma del mantenimento del problema stesso. Esso diventa il presupposto attraverso cui si legge il mondo e l’Altro, che quindi viene completamente assorbito nella definizione di problema di chi osserva.
In un’ottica di responsabilità ci si può chiedere: la progettazione e gli ambiti di lavoro educativo sono gli stessi di 20 anni fa? La cultura scolastica non è cambiata nel tempo? E il rapporto con le famiglie? Quali aspettative guidano l’idea che i genitori partecipino ai progetti educativi della scuola in modo competente? E a chi appartengono queste aspettative?
Nuove frontiere per normativizzare o nuovi criteri per problematizzare, quindi?
Qualcuno intuirà che non si tratta di scegliere la risposta esatta come in un quiz televisivo. La domanda è a servizio di ciò che genera. A noi la responsabilità di essere autori del cambiamento, e per far questo occorre modificare i criteri su cui sono costruiti i problemi, o autori dell’idea, a volte sollevante, di imporre ai bambini la normatività degli adulti.
Bibliografia:
Berger P.L. e Luckmann T. (1969). La realtà come costruzione sociale, Mulino</p Foucault M. (1972), L’ordine del discorso, Einaudi
Goffman E. (2003), Stigma. L’identità negata, Ombre Corte
Salvini A. (2007). Nota Normalità/Anormalità, in A. Zamperini, (a cura di), Psiche, Dizionario storico di Psicologia, Psichiatria, Psicoanalisi, Neuroscienze. Einaudi, Torino.
Salvini A. e Bottini R. (2011), Il nostro inquilino segreto, Adriano Salani.
note: [1] Libri in cui la narrazione si sviluppa attraverso le illustrazioni, senza aggiunta di testo scritto.